Lo stadio di Wimbledon
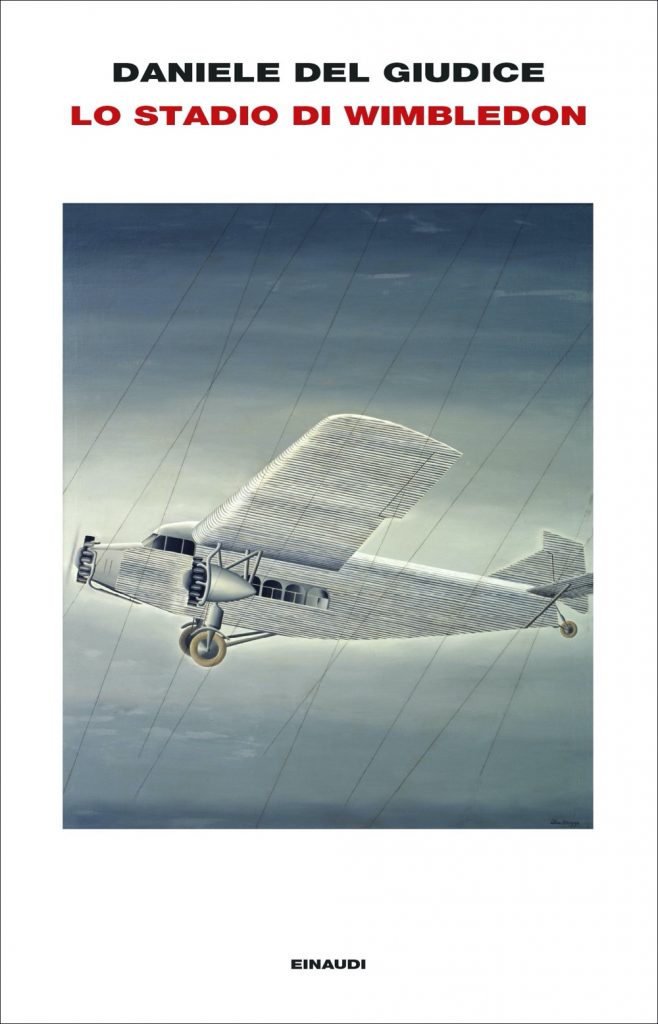
Lo stadio di Wimbledon è il romanzo d’esordio di Daniele Del Giudice, pubblicato nel 1983 da Einaudi con una celebre quarta di copertina firmata da Italo Calvino. L’opera prende la forma di un’indagine attorno alla figura elusiva di Roberto (Bobi) Bazlen, intellettuale triestino interlocutore di molti protagonisti della cultura novecentesca, nonché co-fondatore della casa editrice Adelphi. Una domanda, soprattutto, risulta centrale: quali ragioni hanno condotto Bazlen, lettore sensibilissimo e mediatore eccezionale, immerso nei circuiti intellettuali della sua epoca, a non essere a sua volta scrittore, o a non pubblicare il poco che scriveva? Perché Bobi Bazlen, insomma, ha scelto di essere un «non-scrittore»?
La domanda attorno a questa rinuncia apparentemente sconcertante diviene il motore di una narrazione condotta in forma d’inchiesta: l’anonimo protagonista e narratore compie ripetuti viaggi in treno a Trieste, inseguendo frammenti di memoria e testimonianze che lo conducono infine a Londra, nel quartiere di Wimbledon, di fronte al celebre stadio che dà il titolo all’opera. La risposta alla domanda non viene mai fornita in modo diretto, ma si articola attraverso le voci di persone che hanno fatto parte della vita di Bazlen. Ciascuna testimonianza ne offre un ritratto parziale, contraddittorio, spesso inattendibile. Tuttavia, un elemento ricorrente emerge con sempre maggiore chiarezza: la vera opera di Bazlen è stata la sua stessa vita. È su di essa che egli ha agito direttamente, evitando quindi di passare attraverso la mediazione della scrittura; i suoi “personaggi”, allora, altro non sono che quelle stesse persone su cui Bazlen ha esercitato qualche influenza e che ora ne tramandano la memoria. Bazlen non ha scritto ma ha vissuto, e ciò conduce il protagonista a interrogarsi sulle possibilità di conciliare vita e scrittura.
La rinuncia di Bazlen alla scrittura, inoltre, sembra essere stata motivata anche dalla sua percezione della propria epoca e delle sue coordinate storico-letterarie: tutto è già stato scritto e qualsiasi altra cosa che si scriva rischierà di essere solo mediocre, niente più che una nota a piè di pagina. Tale posizione bazleniana rappresenta per il narratore e per Del Giudice stesso un nodo cruciale. Per lo scrittore moderno – o forse postmoderno –, chiamato a confrontarsi con l’eredità del Novecento, la scelta di Bazlen non può essere ignorata: occorre comprenderne le ragioni, per tentare un percorso differente. Il romanzo si configura allora come una riflessione sul senso della scrittura e sulla sua funzione nel mondo contemporaneo.
Accanto alle testimonianze, un altro elemento centrale per la ricostruzione della figura di Bazlen è costituito dalle immagini. Il romanzo di Del Giudice è profondamente segnato da una riflessione sullo statuto delle immagini, sul loro mutamento nel tempo e sulle difficoltà che il soggetto moderno incontra nel relazionarsi con esse. La memoria di Bazlen viene trasmessa anche per mezzo di fotografie, che generano tuttavia nel protagonista, incapace di metterle a fuoco, un senso di imbarazzo. L’immagine risulta inadeguata a trasmettere ciò che il protagonista ricerca e che si colloca piuttosto in una zona d’ombra, un luogo interstiziale, che è anche lo spazio in cui si situa la letteratura per compiere la propria funzione di intervento sulla realtà, nell’istante che intercorre tra invenzione e memoria. Attraverso le immagini, con la macchina fotografica che simbolicamente il narratore trova di fronte allo stadio, il romanzo affronta anche il tema della rappresentazione, evocato nel riferimento del titolo originario, poi abbandonato, alla Carta di Mercatore.
La perdita del centro focale investe progressivamente, dopo le immagini, l’indagine stessa del protagonista e narratore. L’interrogativo iniziale perde rilevanza, cedendo spazio a un movimento lungo i margini, fatto di deviazioni e riflessioni. Attraverso il racconto dei testimoni – tra cui spiccano le figure di Ljuba e Gerti, già muse montaliane – il protagonista approda a una forma di epifania, in cui il “fantasma” di Bazlen si manifesta imprevedibilmente nella narrazione tramite le sembianze di un dono, quello del pullover di Bobi, che sarà necessario accettare e infine mettere da parte, senza smettere però di prendersene cura. Lo stadio di Wimbledon si rivela così una grande riflessione sullo scrivere, sulla necessità di attraversare la rinuncia per trovare una propria voce letteraria: non in contraddizione con Bazlen, bensì a partire dalla sua posizione e tuttavia per avvalorare una strada contraria, nella convinzione che la scrittura sia ancora possibile.
Il primo risultato, allora, è proprio il libro che leggiamo, Lo stadio di Wimbledon, con cui inizia l’avventura narrativa di Daniele Del Giudice.